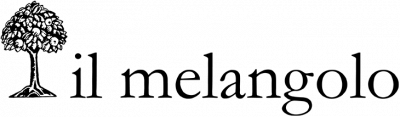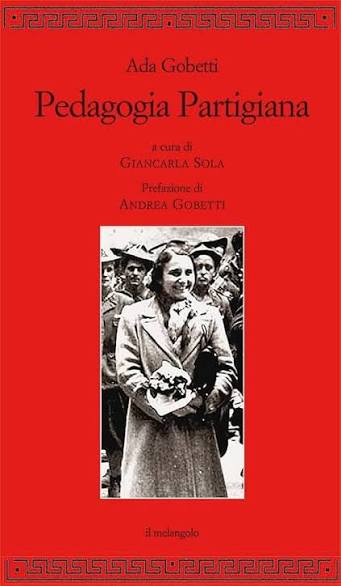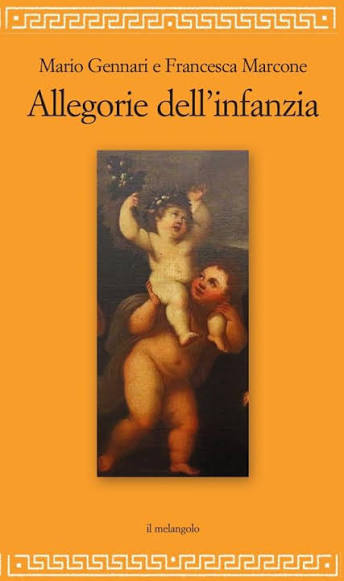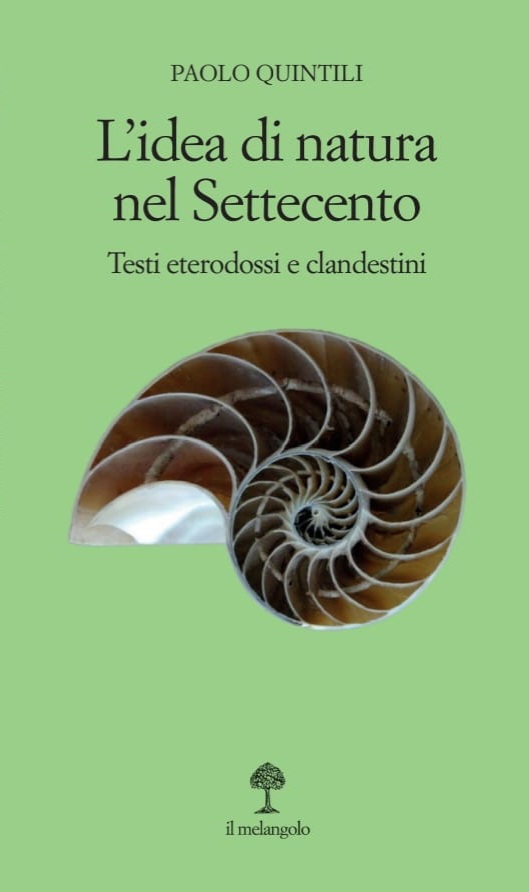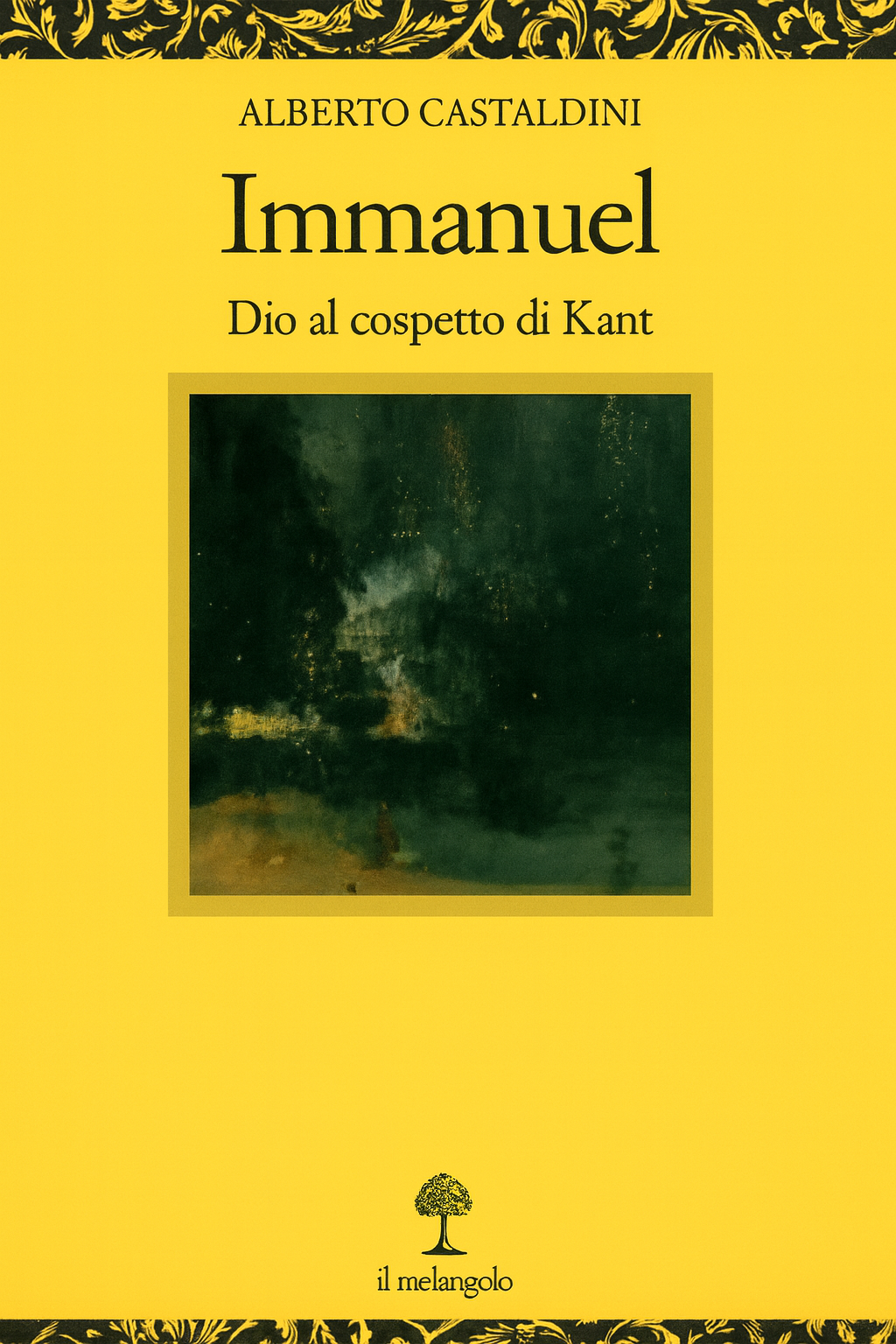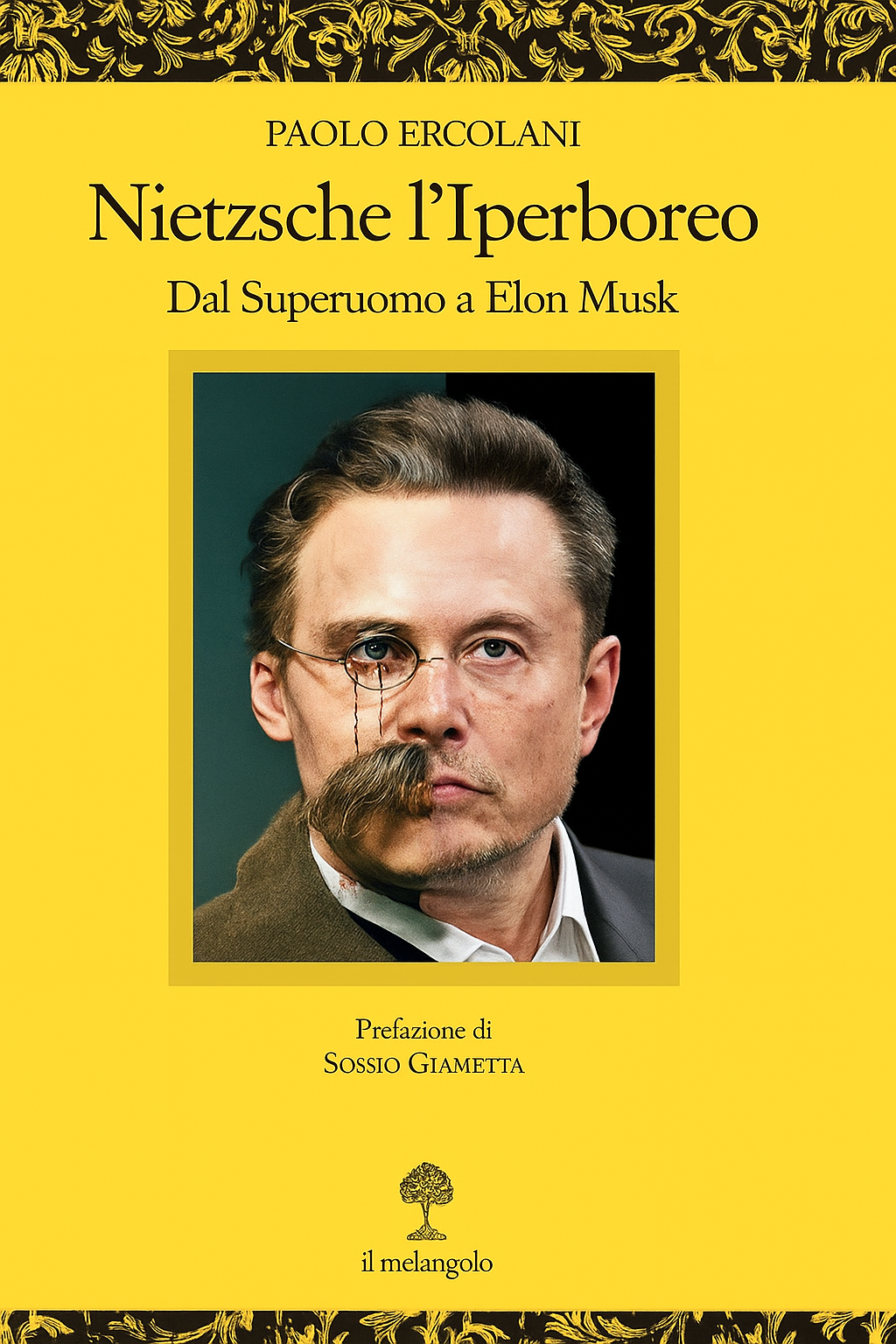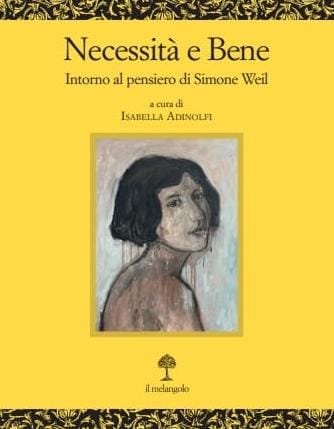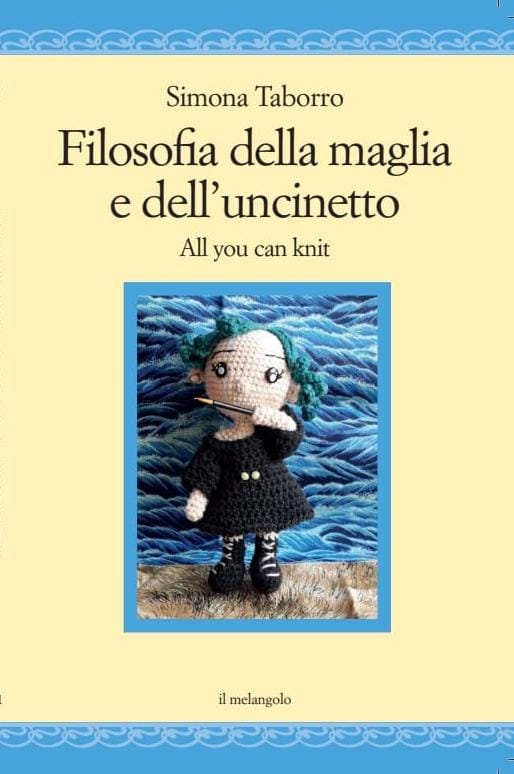Pedagogia partigiana, a cura di Giancarala Sola
Allegorie dell’infanzia
Allegorie dell’infanzia è l’esito di una ricerca condotta da Mario Gennari e Francesca Marcone su questa età della vita, a partire dall’interpretazione di un dipinto ad opera di un Anonimo del Seicento, qui proposto con il titolo Allegoria dell’infanzia. Nel fare ciò, il saggio si sofferma dapprima sul concetto di “allegoria”, sondando poi significati estetici, semiotico-ermeneutici e filosofici che dal quadro affiorano a proposito dell’infanzia pedagogicamente intesa come Oriente della vita. A muovere da questo centro, il cerchio del discorso si amplia tangendo altre poetiche: il poemetto latino di un monaco medievale sulla cura del giardino, la musica rococò, la pedagogia della Hoflichkeit (cortesia) nel trattatello Sulle relazioni umane di Adolf von Knigge, nonché la classicità musicale viennese. È possibile scorgere, in tali Poetiche del Tempo Sospeso, altre allegorie. Con una riflessione sul Semeion e sulla Mousiké il testo ritorna sull’interpretazione, facendo emergere la Semiotica quale dispositivo di indagine in Pedagogia. Su quest’ultima – scienza della formazione, dell’educazione e dell’istruzione culturale dell’essere umano – il volume converge, ponendola in dialogo con altri ambiti scientifici e culturali dell’enciclopedia dei saperi. Il libro volge al termine, profilando alcune considerazioni sul pedantisimo pedagogico, l’antipedagogia e gli idiomatismi di una società puerile di cui le Retoriche Infantili sono a volte intrise.
Mario Gennari è Professore emerito nell’Università degli Studi di Genova
Francesca Marcone è Ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale nell’Università di Genova
L’idea di natura nel Settecento. Testi eterodossi e clandestini
Questo libro raccoglie e presenta, in antologia, una serie di testi poco noti, tratti dalla tradizione della letteratura filosofica eterodossa e clandestina tra la fine del Seicento e il secolo XVIII, anonimi o pseudonimi, manoscritti o a stampa. Per lo più inediti in italiano, tali testi offrono un quadro esaustivo del naturalismo settecentesco, assunto più tardi, in varie forme, dai grandi autori dell’Illuminismo europeo. È il fondo nascosto dell’iceberg intellettuale di cui i vari Shaftesbury, Voltaire, Hume, Condillac ecc. rappresentano le punte più visibili. La galassia degli anonimi, eterodossi e clandestini, ha impresso alla filosofia moderna la svolta decisiva, nel senso della ricezione critica dei “sistemi” di Descartes, Spinoza, Newton e Leibniz. Interpretati in chiave materialista, questi sistemi hanno permesso di costruire una nuova immagine della natura intesa come fucina inesauribile di energia e di forza, in grado di forgiare tutti gli esseri e tutte le forme del vivente, senza l’intervento di un creatore. Tale immagine è infine passata nelle filosofie della natura della fine del secolo XVIII, inaugurando la “sensibilità estetica” e “patetica” nei confronti del mondo naturale che s’affermerà pienamente nei secoli successivi, fino al nostro.
Autore
Paolo Quintili è professore ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte dell’Università di Roma Tor Vergata. Ha svolto intensa attività di ricerca all’estero, a Parigi, dove ha conseguito il PhD in Philosophie (1999) all’Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. È stato Directeur de Programme presso il Collège International de Philosophie (2010-2016). Il suo ambito di studi principale è la storia del materialismo e la filosofia francese moderna e contemporanea. Ha pubblicato: Avatars du rationalisme. Crises de la raison et destins de la philosophie moderne, Paris, 2024; Matérialismes et Lumières, Paris, 20162; La pensée critique de Diderot, Paris, 20162
Immanuel. Dio al cospetto di Kant
«Dio sta al cospetto dell’uomo e l’uomo ne scorge le “fattezze”, può fare tesoro del suo ammonimento, si sente mosso da un impulso che non è semplicemente impositivo o imperativo, ma conformato a un modello che passa da una consapevolezza personale. Dio è così monito alla moralità, ma è anche modello assimilato dal cuore, giacché la coscienza sarebbe incompleta solo per la ragione. Il Dio di Kant è un’idea ma è anche convinzione personale, che fa dell’uomo un testimone persuaso.»
Alberto Castaldini insegna Filosofia della storia presso la Facoltà di Teologia Greco–Cattolica dell’Università Babeş–Bolyai di Cluj–Napoca, in Romania. Giornalista professionista, ha lavorato in quotidiani e riviste di approfondimento sociale e geopolitico. Dal 2006 al 2010 ha diretto l’Istituto italiano di Cultura di Bucarest. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Contra Genesim. Sugli ebrei e la rifondazione antropologica del nazionalsocialismo (Milano, 2019); Dolore del mondo e mistero di iniquità. Il male in Romani 8, 18-39 (Roma, 2020), Il paradigma di Abramo. Tre scritti sul padre dei credenti (Livorno, 2021); L’adesione diabolica. Una sfida antica fra dannazione e salvezza (Milano, 2023; On the Concept of Creaturality in Eric Voegelin, in Eric Voegelin Studies: Yearbook. Democracy and Representation (Paderborn, 2023).
Nietzsche l’Iperboreo. Dal Superuomo a Elon Musk
Cosa c’entra Elon Musk con Friedrich Nietzsche? Ma più in generale: quali legami sottili, misteriosi e inauditi accomunano il pensatore più suggestivo, controverso e terribile della storia filosofica con il movimento tecnocratico che oggigiorno ha preso le redini del mondo e dell’umanità? Questo libro si pone l’obiettivo di rispondere a tali domande e, con l’occasione, ripercorrere oltre duemila anni di storia del pensiero occidentale, mettendo in evidenza come il grande filosofo del Superuomo ha rappresentato un tornante della vicenda umana. Tornante di cui molti non si sono accorti mentre altri lo hanno rimosso volutamente. Invece è necessario comprenderlo e attraversarlo se si vuole evitare che, dopo la morte di Dio, avvenga anche quella dell’umanità come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi.
Paolo Ercolani (Roma, 1972) è docente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Conferenziere nei più prestigiosi festival nazionali, i suoi interventi pubblici sono ospitati sulle pagine culturali del Corriere della sera, su il Fatto Quotidiano e su MicroMega. I suoi libri e articoli scientifici sono stati pubblicati in inglese, tedesco, spagnolo e portoghese, oltre che in italiano. È tra i fondatori e membro del comitato scientifico dell’Associazione internazionale «Filosofia in Movimento» (www.filosofiainmovimento.it) nonché autore costante per «Rai Scuola», «Rai Filosofia» e «Rai Cultura». È condirettore scientifico del Festival Internazionale di Filosofia di Ischia e Napoli. Fra i suoi ultimi lavori, tutti ampiamente recensiti e che hanno suscitato un vivo dibattito a livello nazionale e internazionale: «La Storia infinita. Marx, il liberalismo e la maledizione di Nietzsche», presentazione di Luciano Canfora (Napoli 2011); «L’ultimo Dio. Internet, il mercato e la religione stanno costruendo una società post-umana», prefazione di Umberto Galimberti, (Bari 2012); «The West Removed. Economics, Democracy, Freedom: A Counter-History of Our Civilization», prefazione di Santiago Zabala (London – New York 2016); «Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio» (Venezia 2016, vincitore del Premio Nazionale Com&Te); «Figli di un Io minore. Dalla società aperta alla società ottusa», con la prefazione di Luciano Canfora (Venezia 2019). Il suo ultimo libro è «Nietzsche l’iperboreo. Il profeta della morte dell’uomo nell’epoca dell’Intelligenza artificiale» (Genova 2022), definito «geniale» da Sossio Giametta sul «Domenicale» de Il Sole 24 Ore (in un articolo che è diventato la prefazione di questo libro), e di cui questa rappresenta una nuova edizione ampliata e rimaneggiata.
Necessità e Bene. Intorno al pensiero di Simone Weil
Tra il 1909 e il 1943 si dispiega l’intensa parabola esistenziale di Simone Weil, la pensatrice che continua a essere percepita e accolta come una figura unica, enigmatica, affascinante, inclassificabile. Rivoluzionaria, sindacalista, filosofa, mistica, condusse un’esistenza fatta di azione ma anche di studio e di scrittura febbrili. In vita pubblicò pochi articoli ed era nota soltanto a una ristretta cerchia di amici, ma dopo la morte fu celebrata da eminenti intellettuali come Albert Camus e T.S. Eliot che la considerarono il più grande spirito del Novecento.
Questo libro, strutturato in due parti, si concentra su uno specifico e rilevante nucleo tematico della filosofia di Simone Weil: il rapporto tra necessità e bene. Gli scritti riuniti nella prima parte lo esaminano da diverse angolazioni in stretta connessione con altre nozioni fondamentali della riflessione weiliana, mentre nella seconda sezione si approfondisce il dialogo intellettuale con gli autori da lei letti, meditati e criticati con maggiore intensità, o con le autrici che riflettono delle affinità di pensiero.
Attraverso l’indagine accurata sul frammentario, asistematico, ma densissimo lascito filosofico-letterario weiliano che viene condotta da prospettive diverse, questa raccolta di saggi si propone dunque di metterne in luce la complessità e al contempo la capacità di rispondere ai più profondi bisogni dell’umano, che è il tratto essenziale del suo pensiero. Un’eredità che, in ogni tempo e luogo, può orientare e aiutarci a migliorare le nostre relazioni con noi stessi, con gli altri e con Dio.
Isabella Adinolfi insegna Filosofia della storia, Antropologia filosofica e Storia del pensiero etico-religioso all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Le sue ricerche vertono sul rapporto tra etica e religione, con particolare attenzione a pensatori e pensatrici come Kierkegaard, Pascal, Hillesum, Weil, Arendt, Tolstoj e Dostoevskij.
Collabora con istituzioni e centri di ricerca in Italia e all’estero – tra cui la Società Italiana per gli Studi Kierkegaardiani (S.I.S.K.), il Centro Studi sui Diritti Umani (CESTUDIR) e l’Etty Hillesum Research Centre dell’Università di Gent (EHOC). È membro della European Academy of Religion (EuARe).
Per i tipi della casa editrice il melangolo sono usciti alcuni dei suoi lavori più significativi: Le ragioni della virtù (2008); Etty Hillesum. La fortezza inespugnabile (2011); Studi sull’interpretazione kierkegaardiana del cristianesimo (2012); Il segreto di Abramo. Una lettura mistica di Timore e tremore (2018); Il paradiso sulla terra. La religione di Dostoevskij e Tolstoj (2024). In collaborazione con altri autori e autrici, ha curato per la stessa casa editrice: “Io nel pensier mi fingo”. Seminario leopardiano a quattro voci (2016); L’anti-Babele. Sulla mistica degli antichi e dei moderni (2017); Preghiera di donne (2021); La natura nel pensiero femminile del Novecento (2023).
Filosofia della maglia e dell’uncinetto. All you can knit
Durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, iniziano a girare in rete immagini di un atleta che sferruzza. Chi è? Cosa sta facendo? Lavora a maglia o all’uncinetto? Lui è Tom Daley, pluricampione olimpico di tuffi, e tra una gara e l’altra lavora a maglia. Affermerà poi che il lavoro a maglia è stata la sua “arma segreta” per restare tranquillo e concentrato durante la gara. Il suo divenne un caso mondiale: tutti gli stereotipi legati al lavoro a maglia come pratica da “nonnine” subirono un duro colpo.
Gli effetti di benessere psichico legati al lavoro a maglia e all’uncinetto, con il suo ritmo lento e cadenzato, spingono oggi molte persone, uomini e donne, ad impugnare i ferri. Queste attività artigianali permettono di riscoprire un qui ed ora, un esserci, invece di essere freneticamente proiettati verso un futuro che ci sfugge continuamente; ci permettono di ritrovare un centro, un punto in cui focalizzarsi, il tempo lento della vita. Rispetto ad altre pratiche che si propongono lo stesso scopo, come Mindfullness o Yoga, nel lavoro a maglia e all’uncinetto essenziali sono il rapporto tra mano, occhio e mente, e il risultato fisico di ciò che si è prodotto, che fa da specchio tangibile del nostro operare.
E ora prendi i tuoi ferri – sicuramente in casa ne avrai un paio, magari in un cassetto dimenticati – e inizia il tuo primo progetto. Non hai trovato i ferri, ma solo un uncinetto? Inizia a realizzare il tuo primo Granny Square!
Simona Taborro (Roma 1978) è insegnante di Filosofia e Scienze Umane presso il Liceo Cicognini-Rodari di Prato. Appassionata di filosofia e arti tessili dai tempi dell’università, ha iniziato a elaborarne il legame sul canale YouTube “Il filo della principiante”.