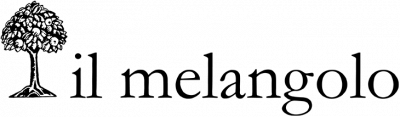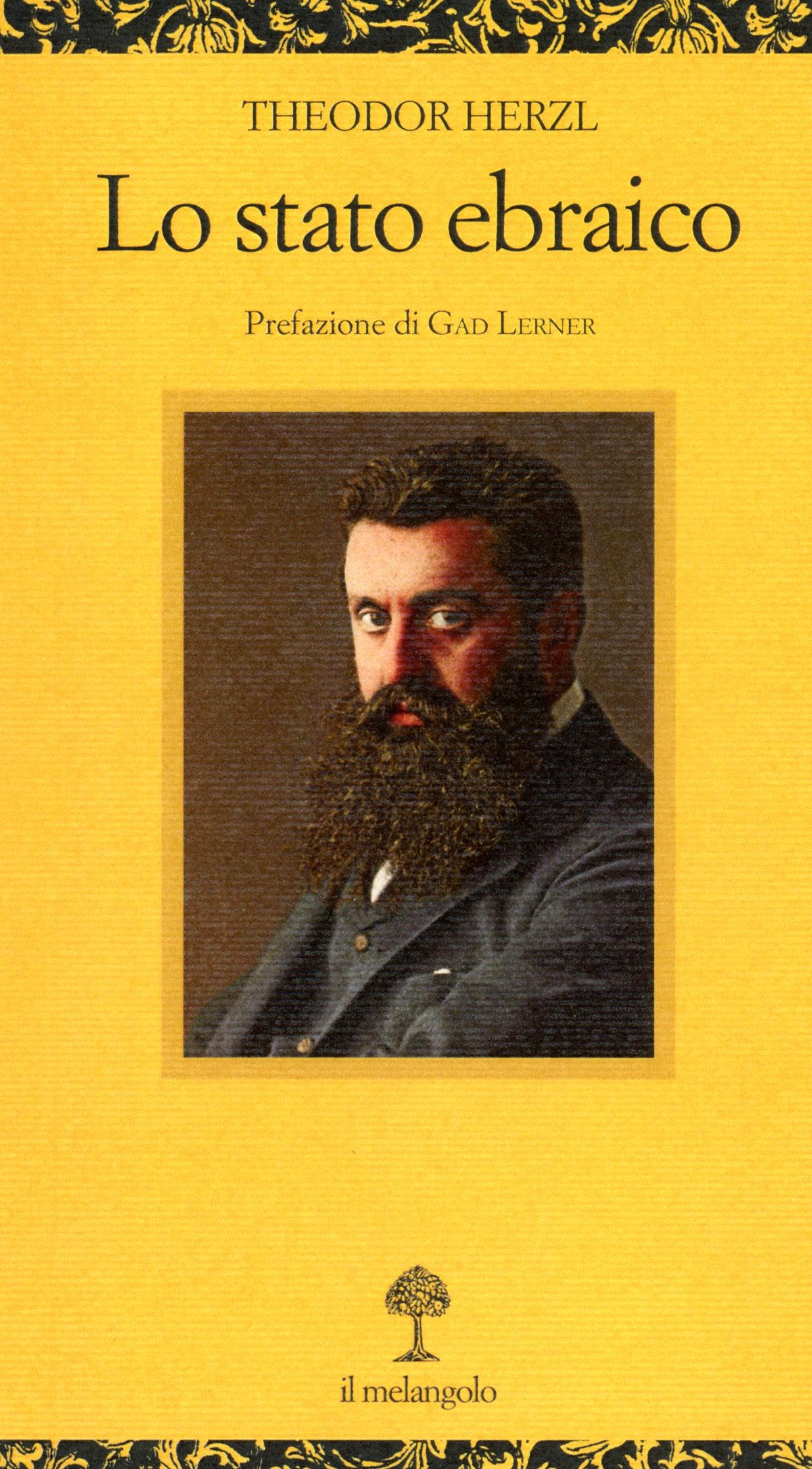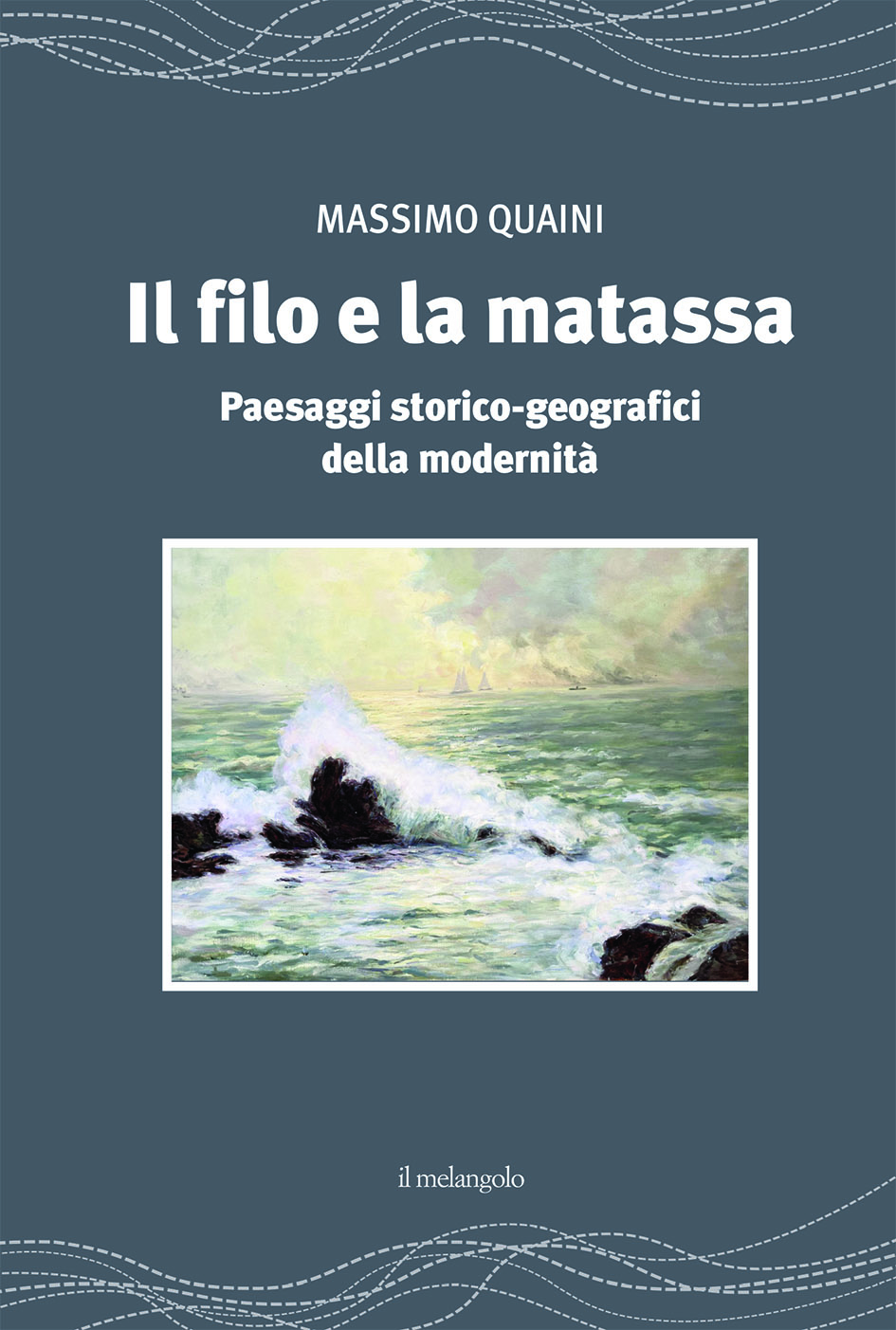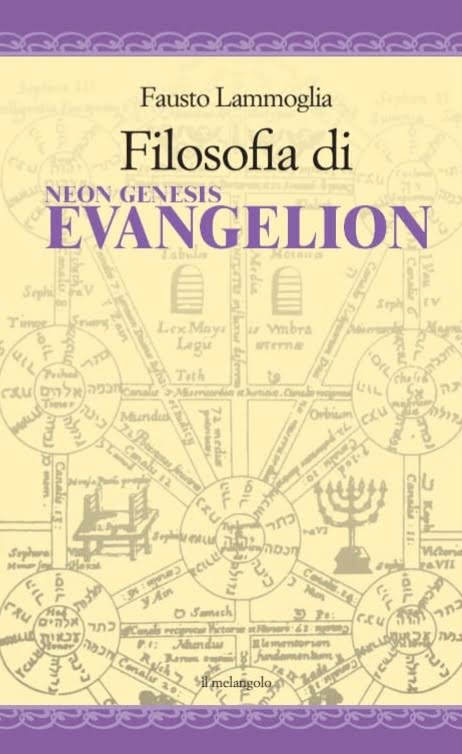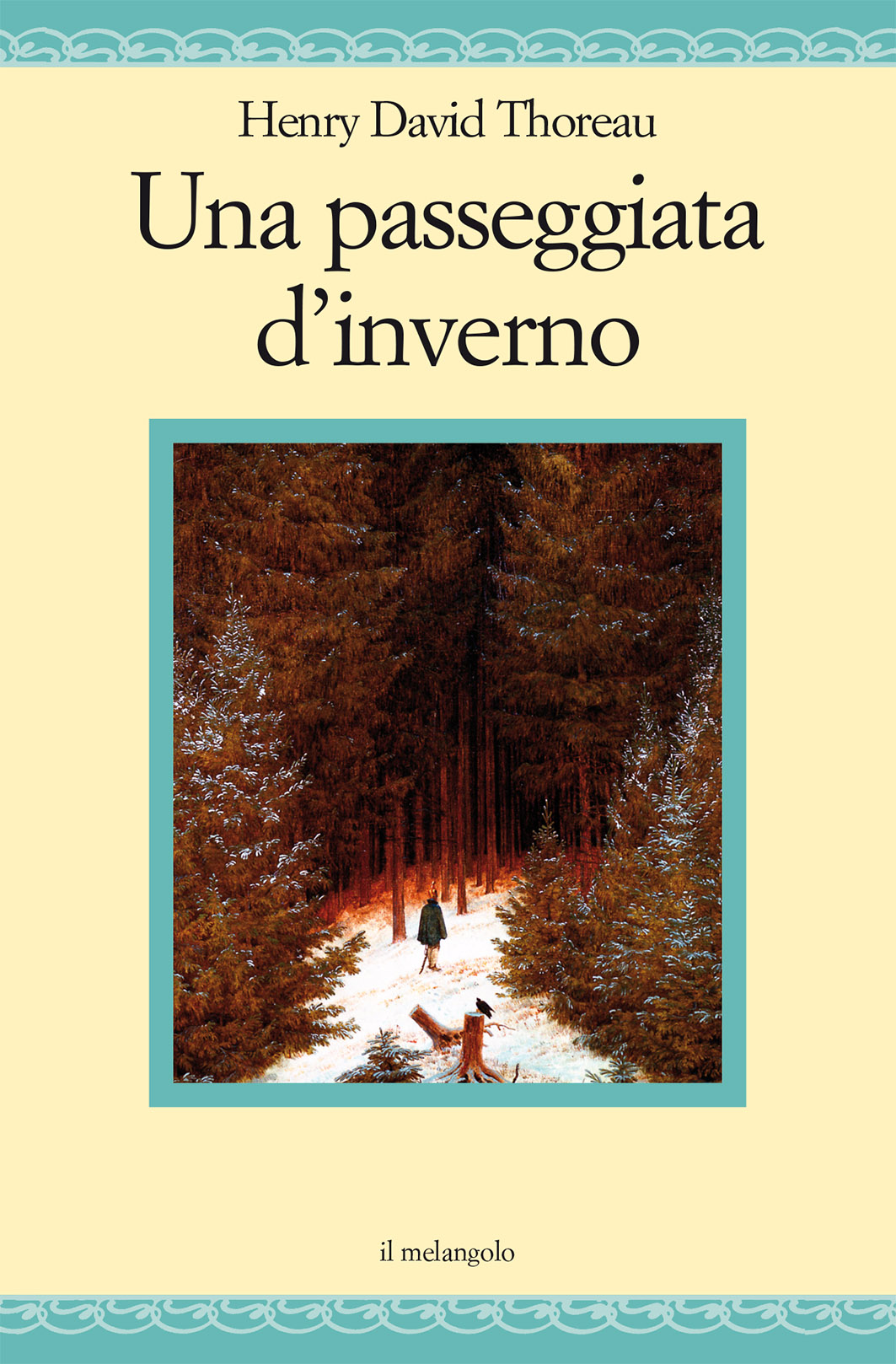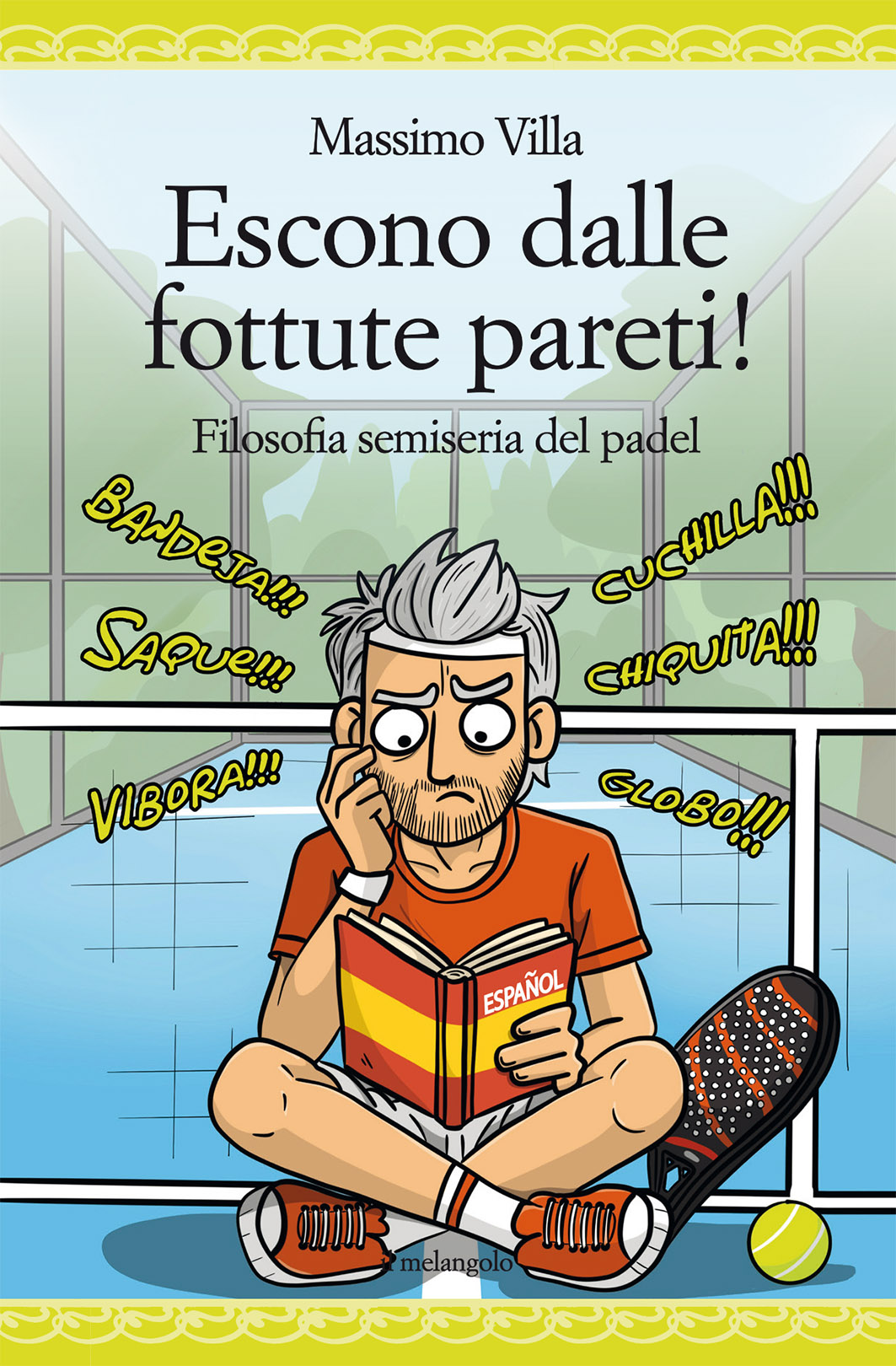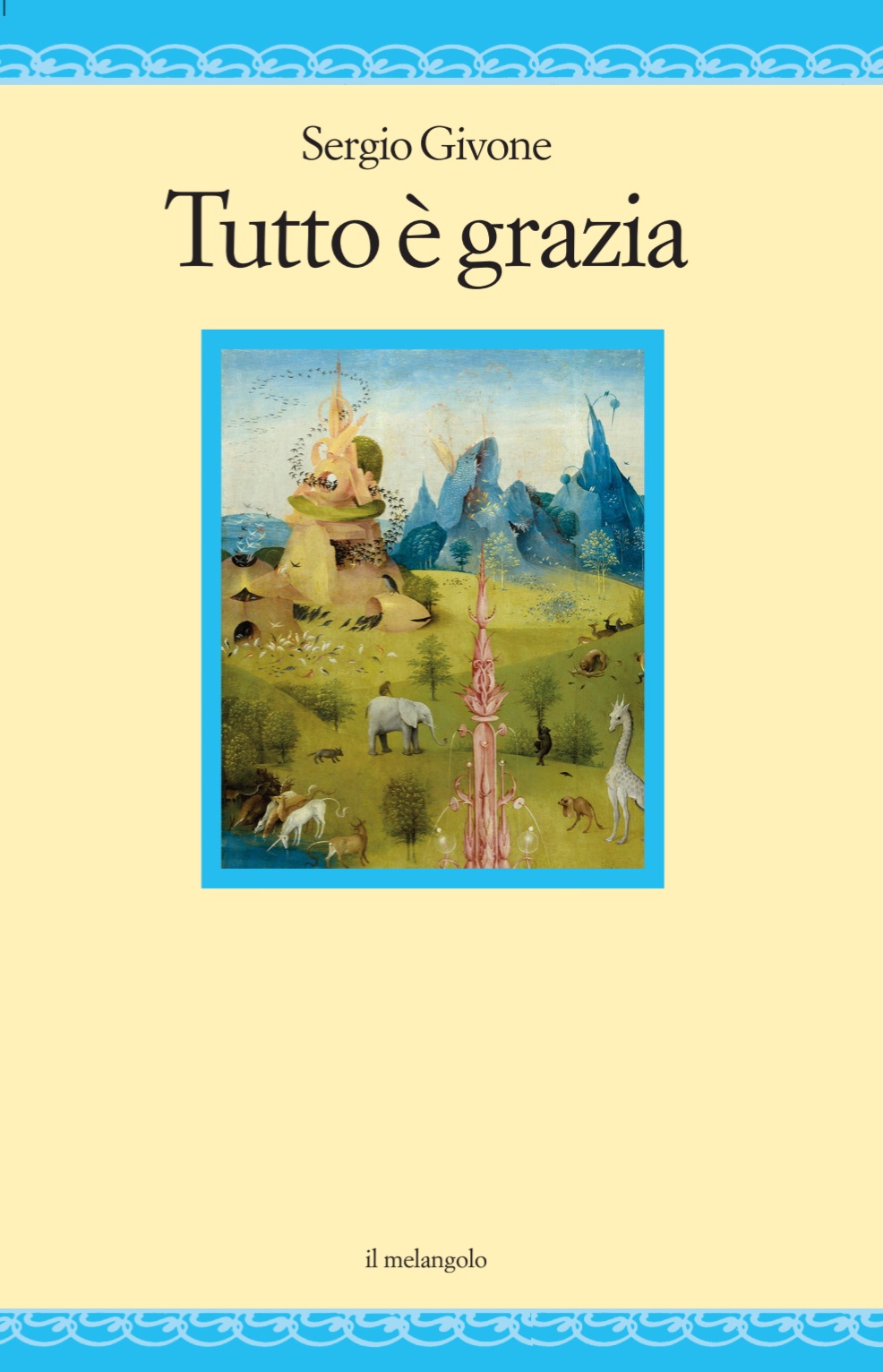Vuoto aurorale
Lo Stato ebraico
!Lo stato ebraico” di Theodor Herzl, edito nel 1896 a Vienna, è il manifesto programmatico del movimento sionista. Scritto come risposta all’antisemitismo crescente della seconda metà del secolo scorso, ha rappresentato il “testo sacro” a cui si sono richiamati gli ebrei di tutto il mondo che, rispondendo all’appello di Herzl, hanno cercato di costruire nella terra dei padri una patria per loro e per i propri figli. Prefazione di Gad Lerner.
Il filo e la matassa. Paesaggi storico-geografici
Il filo e la matassa è soprattutto una storia della geografia italiana ed europea per mappe, attraversamenti e connessioni interdisciplinari, per racconti, generazioni e biografie non soltanto di geografi. Insieme alla storia e a un’idea alta di politica, il paesaggio è il filo che permette di sbrogliare la matassa. In questa prospettiva il saggio vuole essere un cannocchiale sui problemi che fondano la geografia di oggi e di ieri. Oggi la geografia è Cenerentola più fra le scienze naturali che fra le scienze umane. Fra queste ultime ha un ruolo che per effetto della cosiddetta “svolta spaziale” è sempre più rilevante. Anche se non sempre riconosciuto, il suo metodo è praticato da storici e archeologi, da economisti e urbanisti, da antropologi e sociologi, in misura non inferiore all’uso che la geografia fa del metodo e delle principali categorie delle medesime scienze umane e in maniera meno diretta delle scienze naturali. Il suo maggiore merito e compito anche per io futuro è di fare del paesaggio e del territorio il crocevia necessario delle scienze umane. In un’epoca in cui la globalizzazione dei mercati e la finanziarizzazione dell’economia sembrano voler relegare le nostre esistenze ed esperienze in spazi non solo eterodiretti ma anche astratti e virtuali, c’è bisogno di un sapere concreto e legato alla terra. C’è bisogno di geografia. I geografi non possono perdere anche questa occasione e ricongiungersi idealmente con quanto Diderot ebbe a scrivere nell’articolo Uomo dell’Encyclopédie: “Non vi sono vere ricchezze oltre l’uomo e la terra. L’uomo non vale niente senza la terra, e la terra non vale niente senza l’uomo”. Non per caso Elisée Reclus ha intitolato L’uomo e la Terra il monumento finale della sua opera di geografo e che solo oggi riconosciamo come un classico. Ripercorre la vicenda della geografia italiana ed europea negli ultimi due secoli nasce dalla consapevolezza che se oggi riusciamo a guardare lontano, nel futuro, è perché siamo seduti sulle spalle larghe dei giganti del passato e ci muoviamo ancora nel mondo con le loro gambe.
Nota biografica
Massimo Quaini (1941-2017), professore ordinario prima a Bari, poi a Genova, è uno dei massimi geografi italiani. Ha partecipato intensamente alla stagione, aperta da Lucio Gambi, del rinnovamento della geografia italiana. I suoi studi hanno riguardato l’intero ventaglio disciplinare, dalla riflessione teorica alla valenze applicative. Giovanissimo, si è dedicato alle implicazioni geografiche del marxismo, filone sfociato nella pubblicazione di Marxismo e geografia (1974), poi tradotto in diverse lingue. Fondamentale il suo contributo alla storia della geografia, alla storia del viaggio, alla storia della cartografia. Ha fatto della sua Liguria il proprio cantiere di ricerca privilegiato, mettendo in connessione fonti d’archivio e fonti di terreno, saperi dotti e saperi vernacolari. In tale prospettiva ha diretto, con la collaborazione di Diego Moreno e altri colleghi, il Dottorato di ricerca in Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico ambientale. Si è inoltre cimentato nella pianificazione territoriale, iscrivendo il proprio lavoro nell’orizzonte concettuale della Società dei Territorialisti.
La filosofia di Neon Genesis Evangelion
Primariamente dobbiamo aver chiaro quale sia la missione, lo scopo di questo viaggio: ci proponiamo di abitare le domande di senso, rispetto alla nostra esistenza, poste da Hideaki Anno per mezzo della vita di Shinji e compagni. In particolare, ci chiederemo cosa significa esistere come individui; analizzeremo la nostra esistenza attraverso gli occhi degli altri; cercheremo di esplorare il mondo come qualcosa che dipende strettamente dalla nostra narrazione; concluderemo cercando la soluzione al celeberrimo dilemma del porcospino di Schopenhauer che, di fatto, guida buona parte della serie. Ogni riferimento interno all’opera è mirato all’esistenza umana: a partire dagli Angeli, passando per il Magi System arrivando fino agli stessi Eva, ogni elemento non umano è in realtà uno specchio in cui Shinji, Rei, Asuka e tutti gli altri personaggi riflettono loro stessi e il loro modo di esistere.
Dialogheremo con Evangelion per fare insieme filosofia. Questo significa che ci porremo delle domande, interrogheremo i protagonisti e, insieme a loro, proveremo a delineare ambiti di indagini rilevanti per la nostra esistenza. In sintesi, la speranza è che questo testo ti accompagni nella vita di ogni giorno, prima che ad un esame di filosofia Indossiamo dunque le nostre plugsuit, immergiamoci nel LCL dell’entry plug e uniamoci alle altre unità Eva per affrontare questo arduo compito.
Fausto Lammoglia (Savona 1988) è professore liceale di filosofia. Nerd comprovato, si interessa di filosofia della tecnologia, della politica, dell’educazione. Per i tipi del melangolo ha pubblicato: Filosofia di L’attacco dei giganti, 2023.
Una passeggiata d’inverno e altri scritti
“Mentre la terra è rimasta assopita, tutta l’aria è stata viva, con fiocchi leggeri, caduti pian piano, come se una qualche Cerere nordica fosse giunta a regnare, profondendo il suo grano d’argento al di sopra di ogni campo. Improvvisamente mi ridesto nell’immobile realtà di un mattino d’inverno. La neve riposa, tiepida come cotone, poggiata sul davanzale della finestra; i vetri brinati, appena dischiusi, lasciano entrare una luce flebile, intima, che cresce grazie al dolce conforto che incontra”.
HENRY DAVID THOREAU (1817-1862) è stato un filosofo e scrittore statunitense. Tra le sue opere tradotte in italiano: Walden, 2013; Cape Cod, 2011; Camminare, 2009; La disobbedienza civile, 2005.
Escono dalle fottute pareti! Filosofia semiseria del padel
Il padel nasce in Messico alla fine degli anni ‘60 praticamente per non disturbare i vicini di casa di un ricco possidente del luogo. Un’ideazione casuale, che ha generato uno sport che oggi si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo, e in Italia in modo esponenziale. Questo excursus non vuole essere un trattato di gioco e non vuole addentrarsi in statistiche e numeri sterili che potrebbero annoiare sia il neofita che il giocatore esperto. Vuole invece essere, sempre narrando con un tocco di humor, un’analisi delle realtà dei club e delle persone che li frequentano, del gioco in coppia e delle difficoltà che abbiamo, tutti noi, a far uscire dalle pareti le palline (non diciamo dalle griglie per non esagerare!). E anche di quanto sia importante parlare spagnolo per poter giocare bene, del fatto che non sempre è utile guardare i professionisti esibirsi o di quanto sia un’arma a doppio taglio venire dal tennis e credere di saper fare qualsiasi cosa.
Una guida divertente ma accurata su tutto quanto vi permetterà di riconoscervi nella vostra vita all’interno dei circoli e per farvi capire che non siete soli, anzi, è meglio che vi sbrighiate a prenotare il campo sulla app, prima che sia troppo tardi!
Massimo Villa, genovese, alterna romanzi di fantascienza a saggi di varia natura. Tra i suoi libri ricordiamo Frigo leader (Erga, 2018) e Tutti i conigli feriscono (Robin, 2022), Gioco dunque sono. Filosofia del videogamer (Melangolo, 2020), e le biografie musicali dedicate a Necrodeath, Sadist, Extrema e Node.
Tutto è grazia
“Era un caminant quando scappava da quella sua casa più tetra di una prigione e scendeva le colline fino al Po, lo attraversava, e si incamminavo fra le risaie, nella grande pianura, dove l’orizzonte si apriva all’infinito, come ha scoperto la prima volta che è sceso dalla sua collina e si è inoltrato in basso e poi ancora e ancora in giro per il mondo, e già questo lo riempiva di gioia. Ha continuato a essere un caminant quando ha lasciato Mossul, la sua prima sede in terra di missione, e si è messo in strada senza altra meta che non fosse il deserto e camminava camminava camminava nel deserto e nel deserto ha conosciuto la gloria di chi cammina nel deserto. La gloria di chi cammina nel deserto”.
Chi è veramente lo stralunato personaggio che scende dai colli del Monferrato, s’imbarca per il Medio Oriente e muove alla conquista di un impero? Non lo sapremo mai, perché è impossibile, nelle sue gesta da figlio del secolo dei Lumi, separare il vero dal falso, la realtà dal sogno e dall’utopia. Ma noi che lo seguiamo passo passo, in Russia, in Turchia, in America, veniamo a scoprire, rendendocene conto poco alla volta, da quale vortice di storie proveniamo e in quale precipizio della Storia rischiamo di cadere.
Sergio Givone, accademico della Colombaria, ha insegnato Estetica nelle università di Perugia, Torino e Firenze. Tra i suoi libri: Storia del nulla, Laterza 1995, Metafisica della peste, Einaudi 2012 e Trattato teologico-poetico, il melangolo 2017. Questo è il suo quinto romanzo.